I tumori cutanei vengono tradizionalmente suddivisi in melanomi e tumori epiteliali cutanei non-melanomi.
Cute
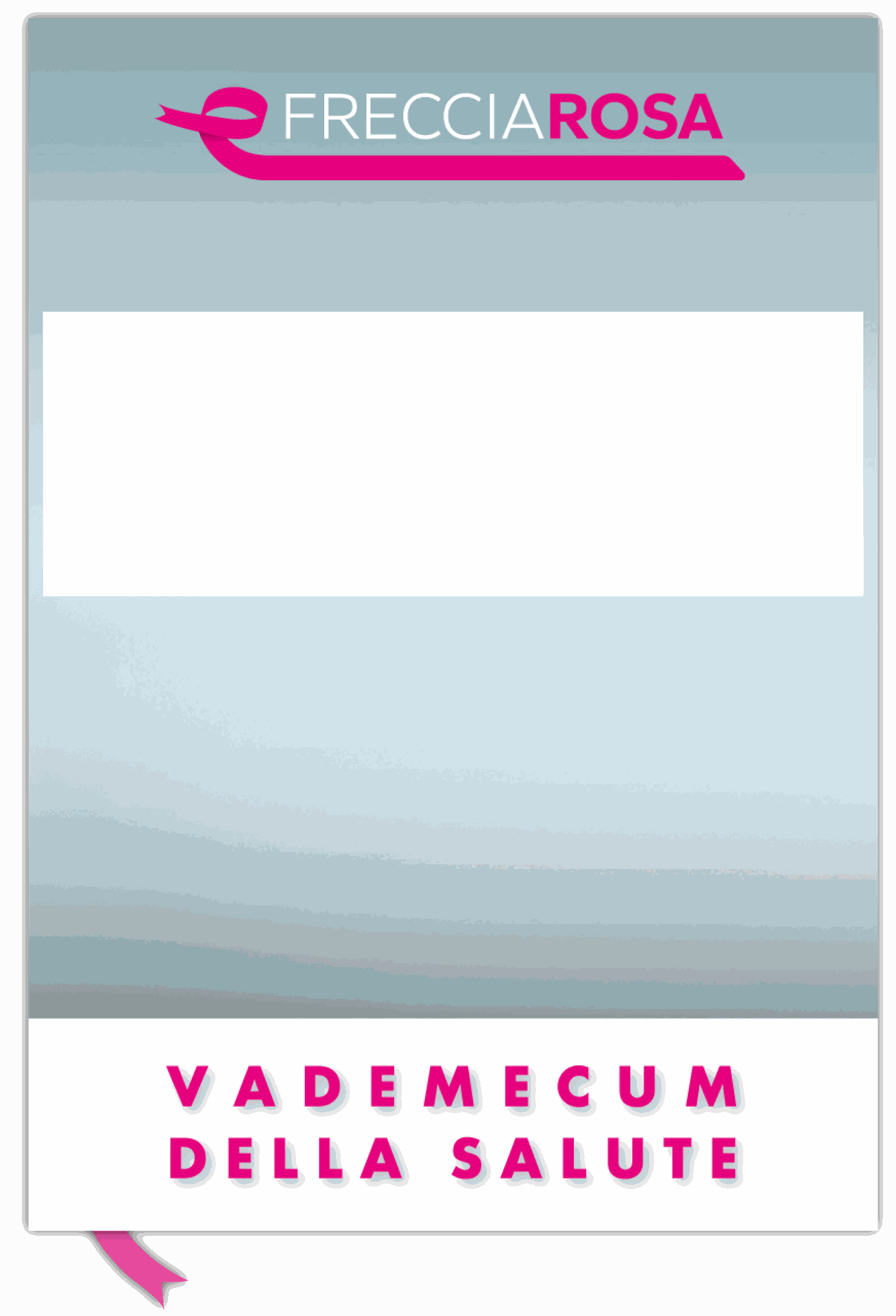
Cute
È un tumore maligno che origina dai melanociti, cellule che contengono il pigmento melanina responsabile della colorazione della pelle. Si può sviluppare nella cute (pelle) di tutto il corpo ma, in rari casi, può insorgere nelle mucose (es. bocca, tratto genitale intestinale, o oculare) oppure può avere un’origine sconosciuta.
I melanomi cutanei originano sia su una cute integra, sia da nevi preesistenti, quindi che sono presenti fin dalla nascita (congeniti) o dalla prima infanzia; o possono svilupparsi da nevi che compaiono durante il corso della vita (acquisiti). Il rischio che un melanoma si sviluppi da un neo congenito è molto basso, a meno che non si considerino i nevi congeniti giganti (superiori a 20 cm) dove il rischio è più elevato.
Dal punto di vista clinico, si distinguono 4 tipi di melanoma cutaneo: melanoma a diffusione superficiale, il più comune, rappresenta circa il 70% di tutti i melanomi cutanei e appare sotto forma di lesione piatta o leggermente in rilievo, spesso con bordi irregolari e variazioni di colore, per lo più sul tronco negli uomini, sulle gambe nelle donne, e nella parte superiore della schiena per entrambi i sessi; lentigo maligna melanoma; melanoma lentigginoso acrale; melanoma nodulare, il più aggressivo, rappresenta circa il 10-15 per cento dei melanomi cutanei. A differenza dei primi 3 tipi, che hanno inizialmente una crescita superficiale, il melanoma nodulare invade il tessuto in profondità sin dalle sue prime fasi.
DATI EPIDEMIOLOGICI
L’incidenza di questo tumore è in continua crescita. Circa l’85% dei melanomi cutanei che insorgono annualmente nel mondo interessa le popolazioni di Nord-America, Europa e Oceania. Si tratta di uno dei principali tumori che insorgono in giovane età e costituisce in Italia attualmente il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni. Nonostante l’aumento dell’incidenza, la mortalità è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi anni.
Il principale fattore di rischio per il melanoma cutaneo è l’esposizione eccessiva e ripetuta alla luce ultravioletta (UV), che arriva fino a noi sotto forma di raggi UVA e UVB, ed è principalmente veicolata dai raggi del sole. Esporsi troppo al sole, soprattutto in età precoce, rappresenta un pericolo, perché può danneggiare il DNA delle cellule della pelle e innescare la trasformazione tumorale e portare all’insorgenza del melanoma, anche molti anni dopo. È importante ricordare che anche le lampade e i lettini solari sono sorgenti di raggi ultravioletti e devono quindi essere evitate. Basti pensare che anni fa lo IARC (l’agenzia per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) ha condotto uno studio che ha evidenziato che l’esposizione anche ad una sola lampada abbronzante al di sotto dei 30 anni aumenta il rischio di contrarre un melanoma del 75%. Il rischio è maggiore negli individui caucasici (di pelle bianca) e aumenta anche nelle persone con lentiggini o con molti nei, in quelle con occhi, capelli e pelle chiara, che hanno riportato molte scottature solari soprattutto se in età pediatrica.
Altri fattori di rischio importanti sono avere un parente stretto colpito da questo tumore o avere avuto un precedente melanoma cutaneo o un diverso tipo di tumore della pelle, come il carcinoma a cellule squamose e il carcinoma basocellulare.
Carcinoma basocellulare (o basalioma) è il tipo di cancro della pelle non melanoma più comune. Origina dalle cellule basali localizzate nello strato più profondo dell’epidermide, a contatto con il derma, e colpisce gli strati superficiali della pelle, in particolare nelle zone foto esposte. È spesso causato dall’eccessiva esposizione ai raggi UV. Si presenta con sintomi come papule rosacee, noduli traslucidi o rossi, ulcerazioni o erosioni persistenti non tendenti alla guarigione, placche rossastre o cicatrici infiammate.
Carcinoma spinocellulare è un altro tipo comune di cancro della pelle non melanoma. Si sviluppa nelle cellule squamose dell'epidermide ed è spesso causato dall’esposizione ai raggi UV, ma può essere favorito anche da fattori genetici e ambientali. I sintomi includono lesioni cutanee squamose e nodulari, che possono sanguinare facilmente.
Carcinoma a cellule di Merkel è una forma rara e aggressiva di cancro della pelle, con alto rischio di recidiva e metastasi. Si manifesta come un rigonfiamento duro, lucido, color carne o rosso-bluastro, che cresce rapidamente senza dolore o sensibilità. Colpisce più frequentemente la pelle esposta al sole, come il viso e le braccia.
Alcuni comportamenti possono ridurre il rischio di sviluppare tumori della pelle. È importante esporsi al sole con moderazione fin dall’età infantile, evitando le ustioni e l’esposizione durante le ore più calde tra le 10 e le 16. Si consiglia di indossare abbigliamento protettivo, cappelli, occhiali da sole e usare creme protettive contro i raggi UVA e UVB con un alto fattore di protezione solare (detto SPF), da applicare più volte e dopo essersi bagnati, in modo da assicurare una copertura continua. Evitare l’uso di lampade abbronzanti. Queste attenzioni sono valide per tutti ma vanno riservate soprattutto ai bambini, molto sensibili alle scottature: il processo di trasformazione tumorale è molto lungo e spesso può derivare da un’alterazione che è avvenuta in età pediatrica. Infine, è importante controllare regolarmente l’aspetto dei propri nei, sia autonomamente che con l’aiuto di un dermatologo o di un familiare per i punti difficili da vedere. Consigliato uno screening da uno specialista ogni 12 mesi.
Il segno principale è il cambiamento nell’aspetto di un neo o la comparsa di uno nuovo. Le caratteristiche di un neo che possono indicare l’insorgenza di un melanoma sono riassunte nella sigla ABCDE. Basta che due di queste lettere corrispondano a un nostro neo per spingerci ad una visita urgente da uno specialista:
- A come Asimmetria nella forma (un neo benigno è generalmente
circolare o comunque ondeggiante, un melanoma è più irregolare); - B come Bordi irregolari e indistinti;
- C come Colore variabile (ovvero con sfumature diverse all’interno del neo stesso);
- D come Dimensioni in aumento, sia in larghezza sia in spessore, anche se i melanomi possono avere un’ampiezza di pochi millimetri;
- E come Evoluzione del neo che, in un tempo piuttosto breve, mostra cambiamenti di aspetto (grandezza, forma, colore).
Tra gli altri campanelli d’allarme che devono essere valutati da un medico vi sono un neo che sanguina anche minimamente, che prude o un neo totalmente diverso dagli altri (segno del brutto anatroccolo).
Un auto-esame periodico della pelle permette quindi in molti casi di identificare cambiamenti dei nei e di rivolgersi per tempo al dermatologo.
Per una diagnosi precoce dei tumori cutanei, è importante una visita dallo specialista ogni 12 mesi.
Lo specialista effettua, in primo luogo, una visita completa nella quale valuta la storia famigliare e la presenza di segni e sintomi tipici del melanoma cutaneo. L’esame visivo della pelle è reso più accurato grazie all’uso dell’epiluminescenza, una speciale tecnica di ingrandimento e illuminazione della pelle. La diagnosi certa di melanoma cutaneo richiede, però, una biopsia in cui la lesione sospetta viene prelevata e poi analizzata al microscopio.
Il trattamento principale per il melanoma è la chirurgia, che spesso riesce a curare definitivamente la malattia in fase iniziale. Con l’avvento di nuovi agenti immunoterapici e terapie a bersaglio molecolare, l’approccio al melanoma avanzato è cambiato, superando l’uso della chemioterapia tradizionale. La scelta del trattamento dipende dall’estensione della malattia, dalla risposta necessaria, dalle condizioni del paziente e da eventuali patologie concomitanti. La radioterapia è utilizzata in alcuni casi specifici, per esempio in presenza di metastasi ossee oppure cerebrali sintomatiche, a scopo terapeutico integrato con altri trattamenti, oppure come palliativo dei sintomi.
Gli effetti collaterali cutanei delle terapie oncologiche sono frequenti e possono variare in base al tipo di trattamento (chemioterapia, immunoterapia, radioterapia, terapie target, ecc.). Possono includere secchezza, rash, prurito, alopecia, fotosensibilità, alterazioni ungueali o della pigmentazione della pelle, e lesioni più gravi in caso di radioterapia o immunoterapia. L’immunoterapia, infatti, ha rivoluzionato il trattamento di diversi tumori, offrendo nuove prospettive di sopravvivenza, soprattutto in neoplasie avanzate. Tuttavia, non è priva di effetti collaterali: può indurre reazioni cutanee come rash, prurito, vitiligine, psoriasi e, in casi rari, dermatiti bollose, a causa della sua azione sul sistema immunitario. Questi effetti non solo possono causare delle ripercussioni significative sulla qualità di vita dei pazienti ma possono anche compromettere il benessere psicofisico e influire sulla continuità e l’efficacia del percorso terapeutico.
È importante quindi che i pazienti oncologici non trascurino questi effetti e che segnalino qualsiasi cambiamento cutaneo all’oncologo o al dermatologo, per poter ricevere il trattamento adeguato e le raccomandazioni più idonee.
Fonti
- Whiteman DC, Green AC, Olsen CM. The growing burden of invasive melanoma: projections of incidence rates and numbers of new cases in six susceptible populations through 2031. J Invest Dermatol.
- Gandini S, Sera F, Cattaruzza MS, Pasquini P, Picconi O, Boyle P, Melchi CF. Meta-analysis of risk factors for cutaneous melanoma: II. Sun exposure. Eur J Cancer. 2005;41(1):45-60.
- Coit DG, Thompson JA, Albertini MR, Barker C, Carson WE, Contreras C, et al. Cutaneous Melanoma, Version 2.2019, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17(4):367-402.
- Michielin O, van Akkooi ACJ, Ascierto PA, Dummer R, Keilholz U. Cutaneous melanoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2019;30(12):1884-1901.
- Morton DL, Thompson JF, Cochran AJ, Mozzillo N, Elashoff R, Essner R, et al. Final trial report of sentinel-node biopsy vs nodal observation in melanoma. N Engl J Med. 2014;370(7):599-609.
- Chapman PB, Hauschild A, Robert C, Haanen JB, Ascierto P, Larkin J, et al. Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation. N Engl J Med. 2011;364(26):2507-2516.
Questa pagina ti è stata utile?
Se ritieni che queste pagine siano utili condividile . Aiutaci anche tu a diffondere la cultura della prevenzione!
Dona oraCon il supporto non condizionante di
















