Negli ultimi anni, i tumori ginecologici hanno subito un’importante evoluzione sia nella fase diagnostica sia nella fase terapeutica, con l’affermarsi di ulteriori armi terapeutiche al di là della chirurgia e della chemioterapia “tradizionali”.
La prevenzione, attraverso controlli regolari e uno stile di vita sano, è fondamentale per ridurre il rischio e favorire diagnosi tempestive.
Collo dell’utero, endometrio e ovaio
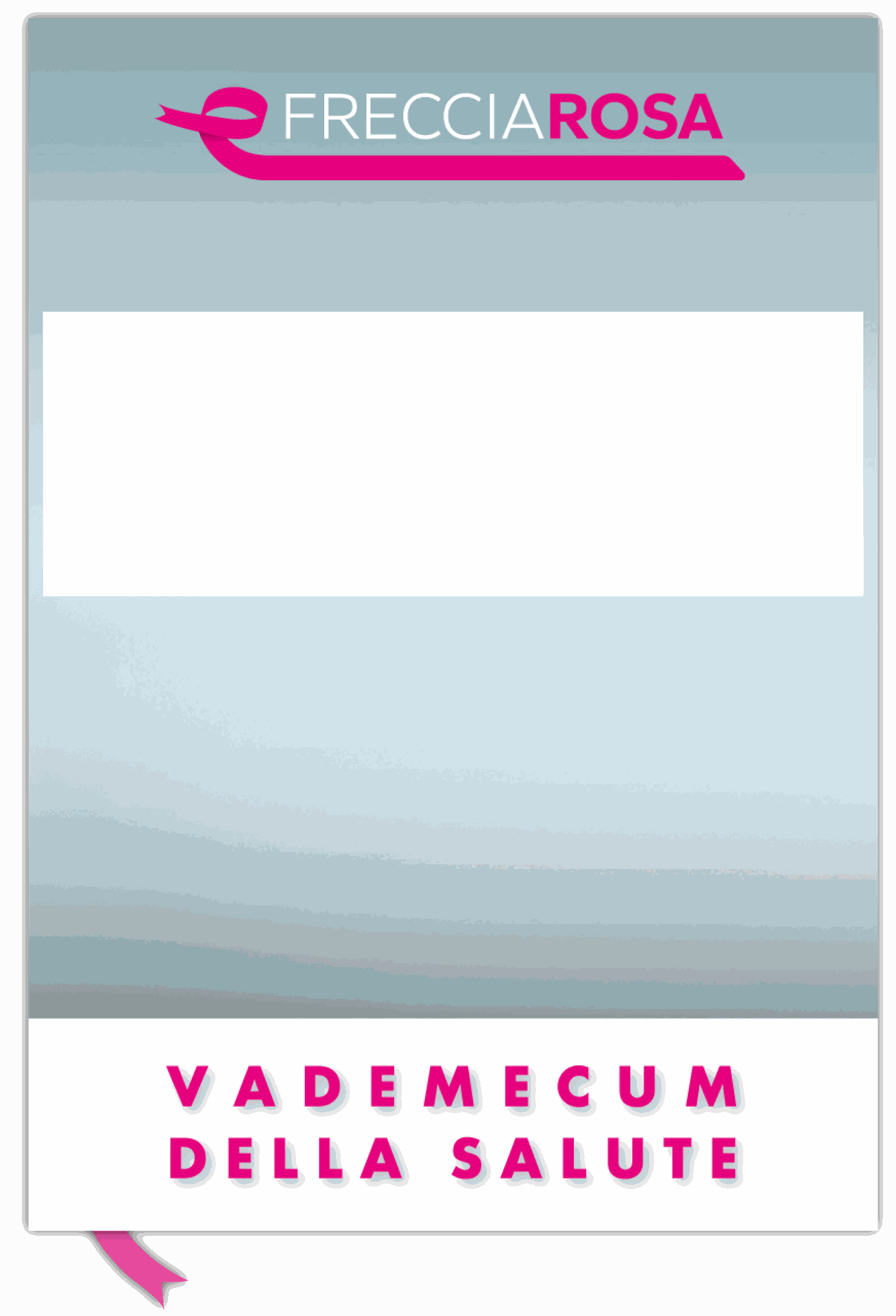
Collo dell’utero, endometrio e ovaio
Il tumore del collo dell’utero è una neoplasia che colpisce la cervice, la parte inferiore dell’utero che si apre nella vagina. È tra i tumori ginecologici più comuni nei Paesi in via di sviluppo e rappresenta il quarto tumore più frequente tra le donne nel mondo.
DATI EPIDEMIOLOGICI
Ogni anno si contano circa 570.000 nuovi casi e oltre 300.000 decessi. Nei Paesi sviluppati, la diffusione di vaccinazione e screening ha ridotto significativamente incidenza e mortalità, mentre nei Paesi in via di sviluppo questi numeri restano alti per la minore accessibilità ai programmi di prevenzione.
Qual è il principale fattore di rischio?
Il principale fattore di rischio è l’infezione persistente da papilloma virus umano (HPV), in particolare i ceppi ad alto rischio come HPV-16 e HPV-18. La trasmissione avviene prevalentemente per via sessuale. L’HPV può causare anche altri tumori (vulva, vagina, pene, ano, bocca e faringe), colpendo anche gli uomini.
La prevenzione: la vaccinazione contro l’HPV e lo screening regolare
In Italia, la vaccinazione anti-HPV è raccomandata e offerta gratuitamente a ragazze e ragazzi a partire dagli 11 anni. Si somministra in due dosi a distanza di 6 mesi; se iniziata dopo i 15 anni, le dosi sono tre. La vaccinazione è raccomandata prima dell’inizio dell’attività sessuale. È previsto un recupero gratuito fino a 26 anni per le donne e fino a 18 anni per gli uomini, se non vaccinati o con ciclo incompleto, con alcune differenze a livello regionale. Il vaccino è efficace anche fino ai 45 anni ed è indicato anche per chi è sessualmente attivo. I vaccini attuali proteggono contro i 9 sierotipi più pericolosi, prevenendo oltre il 90% dei tumori associati all’HPV.
Il Pap test rileva alterazioni cellulari della cervice che potrebbero evolvere in cancro e si consiglia di effettuarlo ogni 3 anni tra i 25 e i 65 anni. L’HPV test individua il DNA del virus nella cervice e ha una maggiore sensibilità nell’identificare infezioni da ceppi ad alto rischio che possono portare al cancro della cervice. Può essere usato da solo o insieme al Pap test ogni 5 anni, a partire dai 30 anni.
Come si tratta il tumore del collo dell’utero?
Il trattamento dipende dallo stadio della malattia e dalle condizioni della paziente. Le opzioni includono:
- Chirurgia: può consistere in una conizzazione (asportazione di una piccola parte della cervice), una trachelectomia (rimozione della cervice conservando l’utero) o un’isterectomia (rimozione dell’utero, totale o radicale).
- Radioterapia: può essere esterna o interna (brachiterapia), usata da sola o insieme alla chemioterapia.
- Chemioterapia: impiegata per tumori avanzati, anche in combinazione con immunoterapia in alcuni casi.
Quali sono le prospettive future per il tumore del collo dell’utero?
La combinazione di vaccinazione, screening e trattamenti mirati ha già portato a importanti risultati nella riduzione della mortalità.
Promuovere l’educazione, l’accesso ai programmi di prevenzione e i trattamenti adeguati è fondamentale per continuare a contrastare questa malattia e migliorare la salute delle persone affette da tumore della cervice uterina.
Il tumore dell’endometrio è una neoplasia maligna che colpisce il rivestimento interno dell’utero. È il tipo più comune di cancro dell’utero, si manifesta soprattutto dopo la menopausa e rappresenta il tumore ginecologico più frequente nei Paesi sviluppati.
DATI EPIDEMIOLOGICI
Si registrano circa 382.000 nuovi casi all’anno nel mondo, con incidenza più alta nei Paesi sviluppati. La sopravvivenza è buona se il tumore viene diagnosticato precocemente, ma cala sensibilmente nelle forme avanzate.
Quali sono i principali fattori di rischio per il tumore dell’endometrio?
Il rischio di sviluppare il tumore dell’endometrio aumenta con l’età, in particolare dopo i 50 anni. Tra i principali fattori ci sono l’obesità, che comporta livelli più alti di estrogeni, e una storia riproduttiva caratterizzata da menarca precoce, menopausa tardiva o assenza di gravidanze.
Anche l’uso di terapia ormonale sostitutiva con soli estrogeni dopo la menopausa può aumentare il rischio. Altri elementi da considerare sono la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) e una predisposizione genetica, come la sindrome di Lynch, che comporta un rischio più elevato per vari tumori, incluso quello dell’endometrio.
Esistono misure di prevenzione per il tumore dell’endometrio?
Anche se non esiste un metodo certo per prevenire il tumore dell’endometrio, alcune strategie possono contribuire a ridurne il rischio. Mantenere uno stile di vita sano è fondamentale: seguire una dieta equilibrata, praticare attività fisica regolare e mantenere un peso adeguato aiuta a controllare i livelli ormonali.
L’uso prolungato di contraccettivi orali combinati può avere un effetto protettivo. Per chi segue una terapia ormonale sostitutiva dopo la menopausa, è importante associare il progesterone agli estrogeni, sotto indicazione medica.
Soggetti con fattori di rischio genetici o familiari, come la sindrome di Lynch, dovrebbero effettuare controlli regolari presso centri specialistici. Inoltre, evitare il fumo e limitare il consumo di alcol può contribuire alla prevenzione generale dei tumori.
Quali sono i sintomi più frequenti e come si fa diagnosi?
Il sintomo più frequente è il sanguinamento vaginale anomalo, soprattutto dopo la menopausa. Possono comparire anche dolore pelvico, perdite vaginali insolite e perdita di peso non intenzionale nelle fasi avanzate. La diagnosi si basa su esame pelvico, ecografia transvaginale e biopsia endometriale. In alcuni casi si ricorre a isteroscopia e a esami di imaging come RM o TC per valutare l’estensione del tumore.
Come si tratta il tumore dell’endometrio?
Il trattamento dipende dallo stadio della malattia. La chirurgia è spesso il primo passo e prevede l’asportazione dell’utero, con eventuale rimozione di ovaie e linfonodi. A seconda dei casi, si può associare radioterapia, chemioterapia o terapia ormonale, quest’ultima indicata anche per le pazienti che desiderano preservare la fertilità.
Che ruolo ha l’immunoterapia nel trattamento del tumore
dell’endometrio?
L’immunoterapia è un’opzione recentemente introdotta in pratica clinica per il trattamento del tumore dell’endometrio nei casi di tumore avanzato o recidivante, sia in combinazione alla chemioterapia che da sola come terapia di seconda linea. I farmaci immunoterapici, come gli inibitori dei checkpoint immunitari (anti-PD-1 e anti-PD-L1), aiutano il sistema immunitario a riconoscere e combattere le cellule tumorali. Risultano particolarmente efficaci nei tumori con alterazioni genetiche specifiche (dMMR o MSI-H).
Il tumore ovarico è una neoplasia che si sviluppa nelle ovaie, organi riproduttivi responsabili della produzione di ovuli e ormoni come estrogeni e progesterone. Può originare dalle cellule epiteliali (superficiali), da quelle germinali (che producono ovociti) o dal tessuto stromale (che produce ormoni).
DATI EPIDEMIOLOGICI
È il quinto tumore più frequente tra le donne e la prima causa di morte per tumore ginecologico. Ogni anno si registrano oltre 310.000 nuovi casi e più di 207.000 decessi nel mondo, con un’incidenza maggiore nei Paesi sviluppati.
Quali sono i fattori di rischio associati al tumore ovarico?
Il rischio di sviluppare un tumore ovarico aumenta con l’età, soprattutto dopo i 50 anni. Anche la famigliarità gioca un ruolo importante: avere parenti stretti con tumori ovarici o mammari può indicare una predisposizione genetica, in particolare in presenza di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2, o di sindrome di Lynch. Tra i fattori di rischio rientrano anche l’endometriosi, alcune terapie ormonali in menopausa (con soli estrogeni), la nulliparità e una storia personale di altri tumori ginecologici o intestinali. Infine, uno stile di vita poco sano, con obesità e dieta ricca di grassi saturi, può contribuire all’aumento del rischio.
Come viene diagnosticato il tumore ovarico?
La diagnosi precoce del tumore ovarico è difficile, poiché i sintomi iniziali sono spesso vaghi e poco specifici. Tra i segnali più comuni ci sono gonfiore addominale, dolore pelvico, senso di sazietà precoce e bisogno frequente
di urinare. In presenza di questi sintomi, il medico esegue una visita ginecologica e può prescrivere un’ecografia transvaginale per valutare ovaie e utero. Esami più approfonditi, come TC o risonanza magnetica, aiutano a capire se il tumore si è diffuso. Il marker CA-125 nel sangue può essere un indicatore utile, anche se non specifico. La conferma della diagnosi si ottiene con una biopsia, analizzando un campione di tessuto.
Quali sono i trattamenti disponibili per il tumore ovarico?
Il trattamento del tumore ovarico dipende dallo stadio della malattia e dalle condizioni generali della persona, ma in genere si basa su una combinazione di chirurgia e chemioterapia.
- L’intervento chirurgico mira a rimuovere il tumore visibile, spesso includendo ovaie, tube, utero e linfonodi.
- La chemioterapia viene solitamente somministrata dopo l’intervento, ma può essere utilizzata anche prima per ridurre la massa tumorale.
- Le terapie mirate questi trattamenti utilizzano farmaci la cui azione è diretta in modo specifico contro un ‘bersaglio’ presente nelle cellule tumorali. Un esempio sono i PARP inibitori, utilizzati come terapia di mantenimento dopo la chemioterapia, oppure gli anticorpi farmaco coniugati approvati per la malattia platino resistente.
- L’immunoterapia, ancora in fase di studio, rappresenta una possibile opzione futura, agendo sul sistema immunitario per contrastare le cellule tumorali.
Per affrontare al meglio la malattia, è fondamentale affidarsi a centri specializzati.
Ci sono mutazioni genetiche che aumentano il rischio di tumore ovarico?
Le mutazioni ereditarie dei geni BRCA1 e BRCA2 sono responsabili di circa il 15–20% dei tumori ovarici epiteliali. Le persone con mutazione BRCA1 hanno un rischio di sviluppare il tumore ovarico tra il 39% e il 46%, mentre con BRCA2 il rischio è tra il 10% e il 27%.
Anche la sindrome di Lynch, legata a mutazioni nei geni di riparazione del DNA, è associata a un rischio maggiore (fino al 12%).
Il test genetico è uno strumento fondamentale per identificare i soggetti ad alto rischio e pianificare una sorveglianza o una prevenzione mirata.
È possibile una prevenzione per il tumore ovarico?
Attualmente non esistono programmi di screening efficaci per la prevenzione del tumore ovarico nella popolazione generale. Nei soggetti ad alto rischio genetico, come quelli con mutazioni BRCA o sindrome di Lynch, è possibile ridurre il rischio con l’asportazione preventiva di tube e ovaie. In questi casi, anche controlli periodici con visita ginecologica ed ecografia transvaginale possono essere utili. Tra i fattori protettivi, si segnalano l’uso prolungato della pillola contraccettiva e uno stile di vita sano, con dieta equilibrata, attività
fisica e controllo del peso.
Che sviluppi ci sono per il trattamento del tumore ovarico?
La ricerca è in continuo progresso, con studi su terapie combinate, trattamenti personalizzati e immunoterapia. Sono in fase di valutazione anche nuovi marcatori biologici, utili per una diagnosi precoce e per monitorare le risposte alle cure. Questi sviluppi puntano a migliorare le possibilità di cura e la qualità della vita delle pazienti.
Fonti
- AIOM. Linee guida NEOPLASIE DELL’UTERO: ENDOMETRIO E CERVICE Edizione 2024, Aggiornata a dicembre 2024.
- Cibula D, et al. ESGO/ESTRO/ESP Guidelines for the management of patients with cervical cancer - Update 2023.
- AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM e PASSI. I numeri del cancro in Italia 2024.
- AIOM. Linee guida NEOPLASIE DELL’UTERO: ENDOMETRIO E CERVICE Edizione 2024, Aggiornata a dicembre 2024.
- Oaknin, A. et al. Endometrial cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, Volume 33, Issue 9, 860 – 877
- AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM e PASSI. I numeri del cancro in Italia 2024.
- AIOM. Linee guida NEOPLASIE DELL’UTERO: ENDOMETRIO E CERVICE Edizione 2021
- González-Martín, A. et al. Newly diagnosed and relapsed epithelial ovarian cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, Volume 34, Issue 10, 833 – 848
- AIOM. AIRTUM, Fondazione AIOM e PASSI, I numeri del cancro in Italia 2024.
Questa pagina ti è stata utile?
Se ritieni che queste pagine siano utili condividile . Aiutaci anche tu a diffondere la cultura della prevenzione!
Dona oraCon il supporto non condizionante di
















