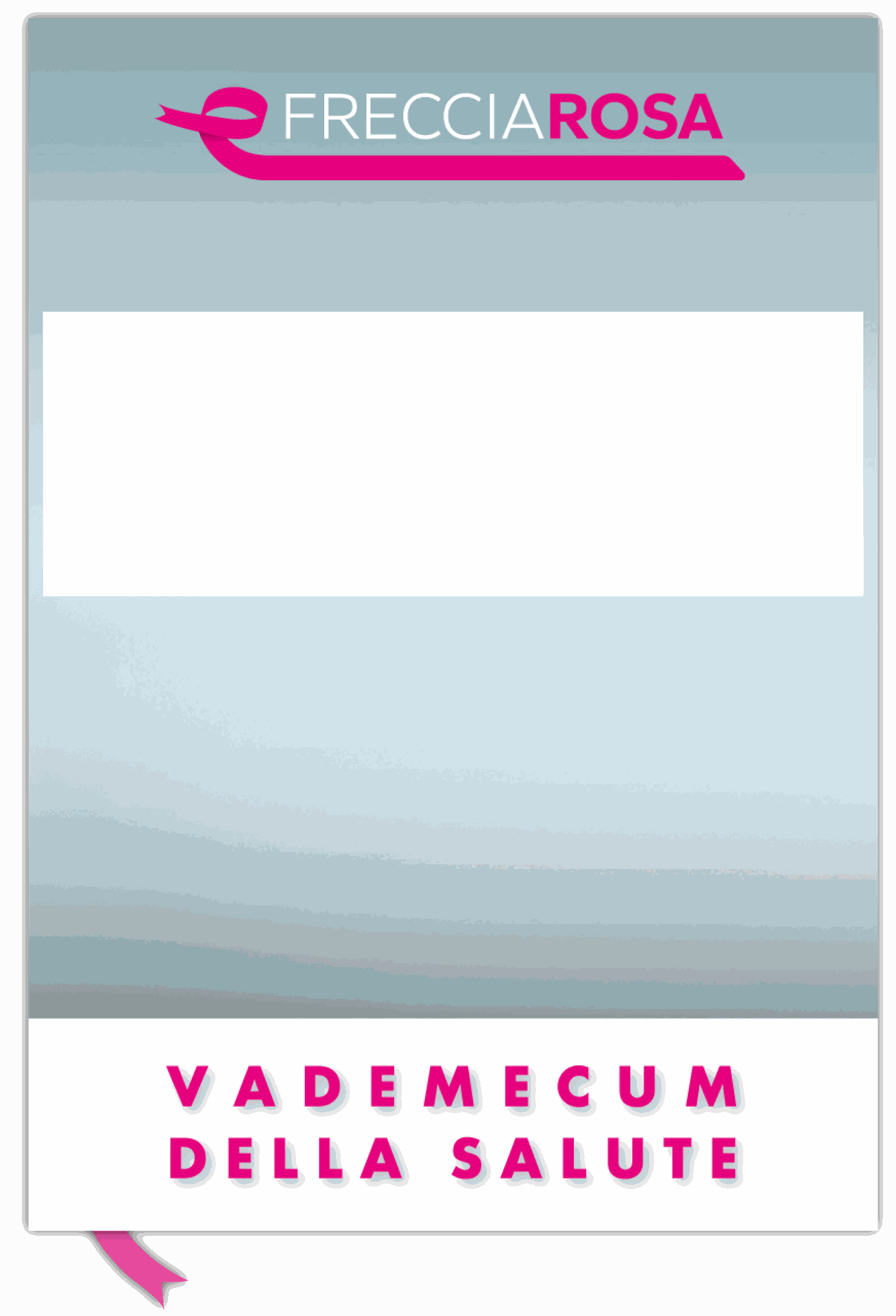Il tumore è provocato dalla formazione di tessuto costituito da cellule che crescono in modo incontrollato. Il 90% dei casi si forma nella parete interna dello stomaco e vengono chiamati adenocarcinomi.
DATI EPIDEMIOLOGICI
Nel 2024, i nuovi casi registrati sono stati 14.105 (8.593 tra gli uomini e 5.512 tra le donne). La sopravvivenza a cinque anni ammonta rispettivamente a 30% e 35%. Si calcola che siano 72.900 le persone viventi in Italia dopo una diagnosi di carcinoma gastrico.
I sintomi sono generici?
Possono essere confusi per quelli di malattie molto meno gravi come gastriti o ulcere. I più frequenti riscontrati dai pazienti sono problemi digestivi, inappetenza, senso di nausea e vomito, senso di pesantezza, dolore o bruciore di stomaco, difficoltà alla deglutizione, presenza di sangue nelle feci o feci nere, stanchezza dovuta ad anemia e importante calo del peso corporeo.
Che cos’è il Helicobacter pylori?
Si tratta di un batterio che può colonizzare il rivestimento dello stomaco (o mucosa gastrica). È un microrganismo molto comune e risulta responsabile di ulcera e gastrite. L’infezione cronica a lungo andare può favorire in alcuni casi l’insorgenza di un tumore dello stomaco. Viene infatti classificato dalla International Agency for Research on Cancer (IARC) come agente cancerogeno di tipo I.
Per questo motivo il batterio va eradicato attraverso una terapia a
base di antibiotici che deve essere prescritta dal medico curante. Il rischio neoplastico si riduce con l’eradicazione e con la sorveglianza endoscopica di eventuali lesioni precancerose già instauratesi.
Come è possibile individuare la malattia?
Con la gastroscopia e la biopsia che consentono la diagnosi definitiva di una lesione tumorale attraverso un prelievo di cellule che vengono poi analizzate, o con una TAC che permette di valutare anche la diffusione del tumore.