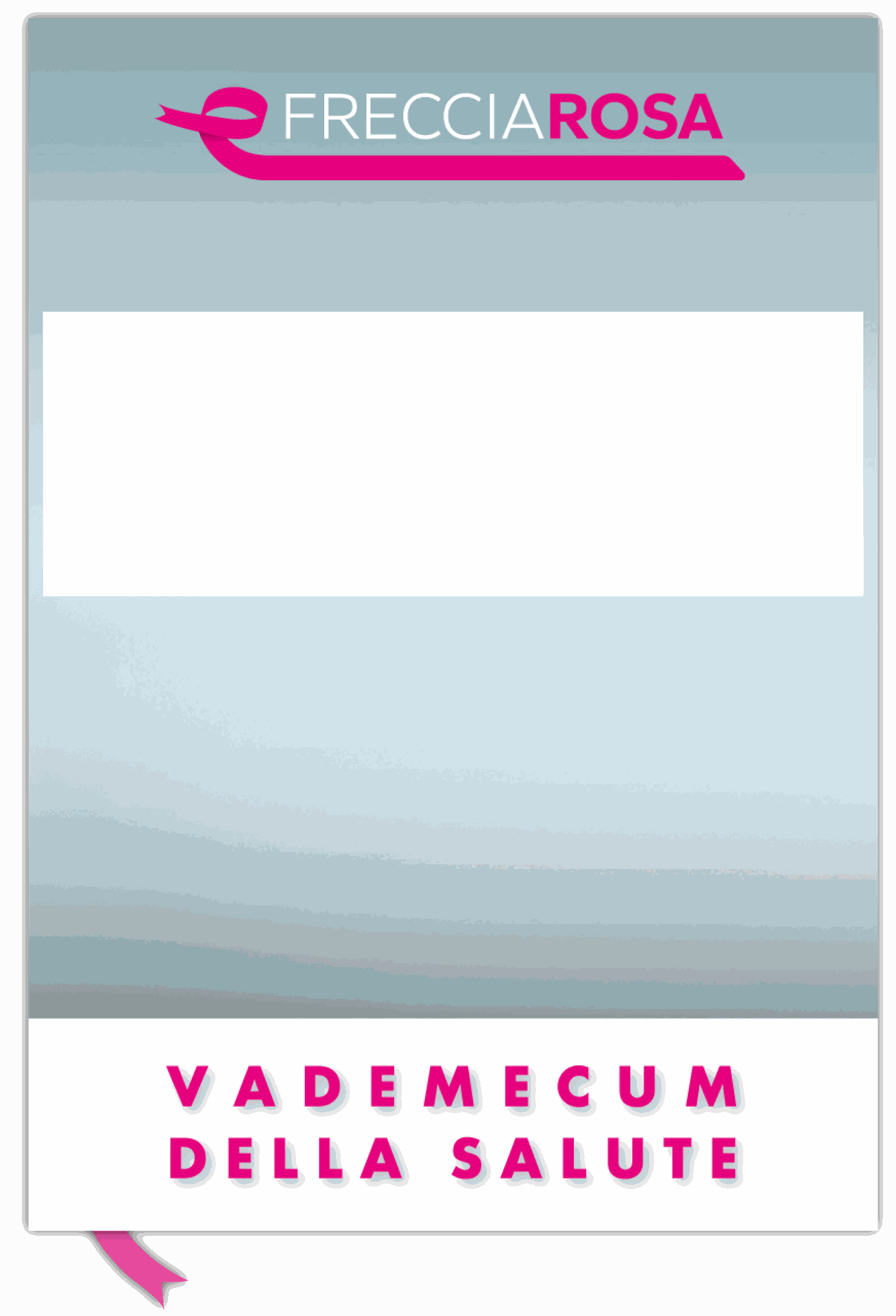PRISCO PISCITELLI
Nel dizionario enciclopedico Treccani pubblicato nel 1955, alla voce “tumore” corrispondeva la definizione di “malattia professionale dei lavoratori dell’industria chimica”, riconoscendo quindi un preciso nesso di causalità.
Questo chiaro riferimento ad un'eziologia del cancro come collegata alle esposizioni a sostanze chimiche è progressivamente scomparso nei decenni successivi, aprendo la porta a spiegazioni generiche basate su una patogenesi “multifattoriale”. Oggi, il cancro è generalmente associato all’invecchiamento della popolazione come conseguenza dell’accumulo casuale di mutazioni da danno genetico ossidativo. L’incremento dei casi di cancro è
inoltre attribuito da molti addetti ai lavori al miglioramento delle nostre capacità diagnostiche: siamo cioè in grado di fare più diagnosi di tumori (vedi screening mammari o della cervice uterina).
Tuttavia, questa spiegazione non chiarisce perché gli aumenti più elevati e più rapidi dell’incidenza del cancro si osservano nelle fasce di età più giovani (ad esempio tra i 25 e i 39 anni si registra il massimo incremento del numero di mastectomie: +23% in sette anni), compresi i bambini (+3.2% di aumento per tutti i tumori sotto 1 anno di età), laddove almeno questi ultimi non sono esposti ai tradizionali fattori di rischio come il fumo di sigaretta (“i bambini non fumano”), fattori professionali o a prolungata adozione dei cosiddetti “stili di vita insalubri”.
L’aumento dell’incidenza del cancro nel primo anno di vita e nei giovani è stato potenzialmente collegato all’esposizione già a livello transplacentare (materno-fetale) o nella fanciullezza ad agenti pro-cancerogeni o alla trasmissione transgenerazionale di alterazioni epigenetiche già presenti nei gameti come conseguenza dell’esposizione genitoriale a diversi contaminanti ambientali nei “primi mille giorni di vita” ma anche durante gli anni fertili dell’adulto.
Si tratta di un cambio di prospettiva rispetto al paradigma eziologico della teoria della cancerogenesi. Infatti, nei giovanissimi non possiamo ipotizzare al contrario degli adulti e degli anziani – un progressivo accumulo di mutazioni casuali (stocastiche) del DNA, come presuppone il modello patogenetico classico (la cosiddetta “teoria delle mutazioni somatiche”, SMT).
Ad esempio se finora un giovane poteva rispondere che fumare sigarette era una sua decisione che non faceva male a nessun altro che a lui (a parte il fumo passivo), oggi sappiamo che le sostanze sviluppate nella combustione delle sigarette al pari di altre esposizioni ambientali potranno produrre alterazioni epigenetiche anche nelle cellule germinali, con trasmissione diretta alle successive generazioni.
Riconoscere la teoria eziologica più appropriata per la cancerogenesi ci consentirebbe di attuare adeguate misure di prevenzione primaria, come la rimozione dell’esposizione individuale a sostanze chimiche e agenti cancerogeni ambientali (Classe IARC 1 e 2). È questa la sfida di una nuova visione della medicina e dell’epidemiologia che sia in grado di cambiare il mondo.
Le statistiche che stiamo generando (che spesso si limitano a "conteggiare” i “morti”, i casi “osservati” e “attesi”) devono trasformarsi in azioni preventive evidenziando tempestivamente le minacce emergenti per la salute delle persone – con un focus particolare sui bambini e sui giovani – al fine di fornire possibili soluzioni. Per raggiungere questo obiettivo, le osservazioni epidemiologiche (che rappresentano i “fatti”) dovrebbero guidare lo sviluppo di coerenti teorie eziologiche della cancerogenesi, così come per tutte le altre condizioni che sono in drammatico aumento anche in età pediatrica: malformazioni congenite, malattie autoimmuni e metaboliche (compreso il diabete di tipo 1) o disturbi del neuro-sviluppo neurologico (ad esempio l'autismo), tenendo conto delle interazioni tra epigenoma, stile di vita e ambiente.
Si apriranno in tal modo opportunità inaspettate per la prevenzione primaria sia farmacologica che non farmacologica e sarà possibile ridurre l’impatto di queste nuove epidemie che caratterizzano il XXI secolo.